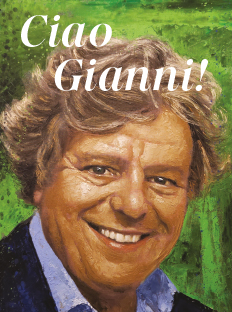La parabola dei talenti è l’ultima della collezione di parabole presenti nel vangelo secondo Matteo. Nell’economia del racconto i primi due servi hanno semplicemente la funzione di bollare, per contrasto, il comportamento del terzo. A differenza dei primi due, quest’ultimo, anziché depositare il talento in una banca, l’ha nascosto in una buca. Perché si è comportato così? Perché si era fatta una idea negativa del padrone, come di un uomo duro, venale e fiscale, che miete dove non ha seminato e raccoglie dove non ha sparso. Fuor di metafora, quel servo si è sbagliato su Dio. Perciò nel suo cuore c’era posto solo per la paura e la più scrupolosa osservanza della Legge (“tutto a misura del dovuto, e nulla più”). Il servo non se l’è sentita di rischiare e ha messo sottoterra il suo denaro, ma non poteva certo aspettarsi che sopra quella zolla di terra ci sarebbe spuntato come per incanto l’albero dello “zecchino d’oro”. Così alla fine si è presentato al suo padrone per restituirgli pari pari la somma ricevuta. E si è ritenuto giusto, sdebitato e inappuntabile perché finalmente gli ha potuto dire in faccia: “Rieccoti il tuo bel talento”. Per lui la “giustizia” va concepita come un rapporto di parità: tanto quanto. Come in fondo la pensano anche scribi e farisei, gli zelanti, puntigliosi osservanti della Legge. Del resto anche noi siamo tentati di pensare come il servo in questione: in fondo cosa ha fatto di male? Il talento, lui, non l’ha né smarrito, né dilapidato: l’ha semplicemente restituito al 100%, tale e quale l’aveva ricevuto. Non è stato forse onesto e fedele? Perché dunque merita di essere trattato dal padrone come un servo malvagio e pauroso (= “che non si decide”)?
Non ne veniamo a capo finché non entriamo nella logica evangelica. Per Gesù è l’amore la misura della giustizia, e non il contrario. L’amore è senza calcoli e senza interessi, senza scrupoli e senza paure. L’amore rischia, non conteggia. Noi invece preferiamo stare sul sicuro. Oggi uno degli idoli più seducenti – e più prepotenti! – è proprio l’idolo della sicurezza. Strade sicure, città sicure, rapporti sicuri. E ci assicuriamo contro le malattie, i furti e gli infortuni… Ma più ci assicuriamo, e più insicuri ci ritroviamo. E anche sotto il profilo religioso, il cristiano migliore sembra essere quello che se ne sta buono buono, sul sicuro. Si attiene minuziosamente a tutte le regole, osserva tutte le norme e i precetti, e, soprattutto, sta ben attento a non sbagliare, a non peccare, a non fare il male. Quando invece dovrebbe preoccuparsi di fare il bene più che di non fare il male. Comunque, siamo poi così sicuri che questa mentalità, apparentemente così saggia e sensata, non sia in verità la più in-sensata e più sciocca? In fondo ne siamo più che certi: ben che vada la vita, non ne usciamo vivi. Benché firmiamo polizze su polizze di assicurazione sulla nostra vita, alla fin fine la vita nessuno se la può assicurare. Comunque sia, all’ultimo la si perde. Ma allora, se si deve perderla, tanto vale spenderla. Tanto vale impiegarla e donarla. Insomma la vita – ecco cosa vuole farci intendere il Vangelo – va rischiata. Certo, rischiando, si può anche sbagliare, ma lo sbaglio più grosso non è forse quello di non fare niente?
Capiamo allora quale sia il talento-base che ci viene gratuitamente donato e cosa significhi concretamente raddoppiarlo e moltiplicarlo. Il talento-base è l’amore che Dio ha per ognuno di noi. Per il fatto stesso che sono al mondo, è perché Dio Padre mi ha voluto, mi ha scelto, chiamato, benedetto. In una parola mi ha amato e basta. Tutto ciò che ho ricevuto e sono, tutto, proprio tutto l’ho ricevuto in dono. Se dunque il talento è l’amore che il Padre ha verso di me, quel talento si deve “duplicare” nella mia risposta d’amore verso i fratelli. Capiamo allora perché questa ultima parabola di Gesù viene collocata dall’evangelista Matteo prima del giudizio universale, in cui il “re” separerà gli uni dagli altri, e dirà: “Ero affamato, assetato, straniero, nudo, malato o in carcere e voi mi avete – o non mi avete – amato e servito”. Siamo dunque chiamati a fare con i poveri ciò che il Signore per primo ha fatto con noi.
Ma il Signore non ci ha amati per scherzo o a parole, ma con i fatti. Perciò anche noi dobbiamo amare non a parole, dicendo ai poveri, che sono affamati o coperti di stracci: “Andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi” (cf. Gc 2,20). I poveri rappresentano la “carne di Cristo”. Sono il sacramento del suo corpo crocifisso, da riconoscere non solo sotto le specie eucaristiche esposte sull’altare e custodite nel tabernacolo, ma anche lì dove essi si ritrovano prostrati, ai margini delle strade, nelle periferie più estreme, nei sotterranei della storia. Solo così asseconderemo l’invito rivolto da Gesù a chi ascoltava la sua parabola del buon samaritano: “Vai e fai anche tu lo stesso”. Solo così sperimenteremo la verità annunciata dal Papa, quando dice che i poveri “non sono un problema”, bensì “una risorsa a cui attingere per accogliere e vivere l’essenza del Vangelo”.
Questa prima Giornata mondiale dei poveri non ci serva da tranquillante per farci sentire a posto, ma ci sia di provocazione per “creare tanti momenti di incontro e di amicizia, di solidarietà e di aiuto concreto” nei confronti di chi si ritrova impastoiato in qualsiasi tipo di povertà. Da quella che costringe a saltare quasi ogni giorno i pasti a quella che costringe a indossare vestiti laceri e sporchi, o ad andare in giro con le scarpe sfondate e a dormire sotto i ponti e dentro i cartoni. E quella che impedisce di comprare le medicine per curarsi, o il biglietto del treno per andare a trovare i propri familiari, o un mazzo di fiori da portare sulla tomba dei propri cari. E quella ancor più spietata che degenera in delusione e disperazione, in rabbia e violenza, al limite nel suicidio. O quella che non riconosce il diritto a frequentare la scuola, ad imparare le parole adatte per chiedere aiuto o per rivendicare i propri diritti, e tramite cui poter fruire di “quell’altro pane” senza il quale l’uomo non può vivere. Ma solo sopravvivere.
+ Francesco Lambiasi



 Max 19°
Max 19°