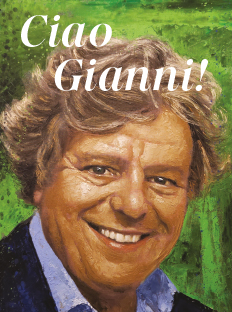I giornalisti della mia generazione hanno molto amato il Perugia della fine degli anni ’70: e ovviamente Perugia. E non solo - almeno per quanto mi riguarda - perché mi stavo avvicinando al bellissimo traguardo dei trent’anni, ma perché andare a vedere quella squadra rappresentava una boccata d’aria buona sotto tutti i punti di vista.
Straordinario, per intelligenza imprenditoriale e per tratto umano, il suo presidente Franco D’Attoma; di una modernità assoluta il suo allenatore Ilario Castagner che in un paio d’anni aveva portato dalla B ai vertici della Serie A una squadra praticamente senza stelle (a parte forse Novellino e Bagni), ma assolutamente piena di luce calcistica. Eppure…
Eppure fu proprio a Perugia, nello stadio che allora si chiamava convenzionalmente “Pian di Massiano” e che avrebbe cambiato nome proprio per quello che accadde quel giorno, che esattamente il 30 ottobre di quarant’anni fa, il mondo della nostra innocenza nel raccontare calcio ci rovinò addosso.
Era una giornata molto fredda: di pioggia non sferzante, ma gelida. Sul campo fradicio, due delle quattro squadre prime in classifica a pari punti: il Perugia, appunto, e la fortissima Juventus di Giovanni Trapattoni che di lì a pochi mesi avrebbe alimentato per otto-nove undicesimi la formazione titolare della Nazionale di Bearzot ai Mondiali d'Argentina
Da una parte, dunque, l’invincibile armata. Dall’altra bucanieri coraggiosi i cui nomi potrebbero dir poco ai ragazzi di oggi: Grassi, Nappi, Dall’Oro, Matteoni….E poi Frosio, Zecchini, Amenta, Speggiorin… C’era anche Walter Sabatini. E c’era Curi… Renato Curi. Aveva 24 anni da un mese il trottolino di Ascoli cresciuto a Pescara: e la maglia numero 8. E allora chi aveva la maglia numero 8 doveva correre, correre tanto, correre per tutti. E far pulsare il cuore della squadra. Ma anche il suo.
E Renato aveva corso per l’intero primo tempo: aveva anche piedi buoni, era stato forse il migliore in campo. Era alto 1 metro e 65: l’altra mezz’ala, Franco Vannini, 1 metro e 90. Da soli, così bizzarramente assortiti, avevano tenuto in scacco il centrocampo dei Campioni d’Italia (quei Campioni a cui un suo gol, un anno e mezzo prima aveva sfilato lo scudetto a favore del Torino). Al quinto del secondo tempo Curi si accasciò senza apparente motivo. L’arbitro Menegalli fermò il gioco vedendo l’agitarsi angosciato accanto a lui di alcuni compagni, di Benetti, di Bettega, di Scirea. In tribuna arrivò l’onda dell’incredulità e della disperazione. Un’onda ancora più gelida di quella giornata
Il massaggio cardiaco, la respirazione bocca a bocca, la barella, il caos… Lo sgomento. Renato arrivò morto al Policlinico. La partita si trascinò fino allo 0 a 0 finale in un angosciante, frastornato play back
Il giorno dopo scoppiarono, inevitabili, le polemiche. Noi giornalisti dovemmo cambiare cappello e farci medici e avvocati; rintronati da voci e teorie. Personalmente presi anche una querela che si risolse nel nulla, ma di cui non vado certo fiero. Ricordo ancora un termine appreso allora: ”pancardite reumatica”. Ci fu chi disse che Renato sapeva di essere a rischio e che il suo non fosse, come diceva scherzando, soltanto “un cuore un po’ matto”. Ci fu invece chi sostenne che fosse perfettamente idoneo. Inutile e irrispettoso, almeno oggi, rivangare quelle dispute sterilmente tardive
In tribuna, quando si consumò quella tragedia, c’era sua moglie Clelia. La piccolissima Sabrina era rimasta a casa. Clelia non sapeva di avere in grembo un bimbo. Che sarebbe nato otto mesi dopo. E che si sarebbe chiamato come il suo papà. E poi come lo stadio di Perugia.
Quel bimbo lo vidi per la prima volta, durante una puntata di “Quelli che il calcio”, poco più di vent’anni dopo. Era venuto anonimamente tra il pubblico. “Sono Renato Curi” mi disse. Lo abbracciai, piangendo le lacrime che non avevo pianto allora.
Marino Bartoletti



 Max 19°
Max 19°