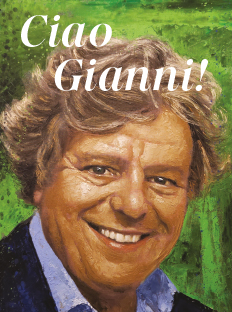Di tutte le arti, l’architettura è l’unica pericolosamente legata al territorio, allo spazio entro il quale è sorta e che ha concorso a modellare; ancorata agli elementi circostanti che la vivificano. Il Palazzo dei Musei di Reggio Emilia, progettato da Italo Rota e inaugurato (dopo ben tre anni di lavori) nel 2015, ha preso in carica la più intima espressione di tale concetto. Innovativo, ma non troppo. Il compianto Umberto Eco, nella metà degli anni ’80, in collaborazione con Jack Lang-allora ministro della cultura francese-organizzò un convegno internazionale dal titolo “Il museo parla al pubblico?”. In tale contesto propose due tipologie di musei: una dedicata ad una sola opera ricostruita nel proprio contesto, l’altra destinata a conservare oggetti comuni riferiti al territorio e capaci di narrare la vera storia delle persone e i loro affetti. La proiezione di un’anima dall’occhio lungo. Lo stesso che nel 1962, con il famoso saggio “L’opera aperta”, teorizzò la necessità che l’arte e l’architettura fossero al servizio di una “storia aperta”. Il Palazzo dei Musei è la concretizzazione di tale democratica teoria museologica. In questo spazio espositivo, sorto sulla struttura di un antico monastero, si possono trovare diverse collezioni artistiche e archeologiche ma anche –e qui la novità- piccole e curiose raccolte di comuni cittadini. Tutti (cittadini e visitatori) possono accostare e aggiungere alle storie narrate dagli oggetti in esposizione i propri vissuti e le proprie esperienze. Il “Museo dei Musei”, cosi come lo definisce lo stesso Rota, diventa quindi il custode del vissuto della città e dei viandanti in pellegrinaggio. Non mette in scena se stesso. Un museo che diventa tale attraverso il ruolo degli interpreti. Aperto, ma l’Eco rimbomba comunque.
Stefania Bozzo



 Max 13°
Max 13°